12 Appunti - gennaio 2026
Imparare a morire
C’è un modo di pensare la morte non come un evento che irrompe dall’esterno, ma come una conclusione alla quale veniamo preparati durante la vita. Non nel senso che la desideriamo, né che la giustifichiamo, ma in quello che diventa progressivamente più comprensibile, più pensabile, meno assurda. Due sono i principali dispositivi di questa preparazione: il nostro rapporto con i defunti e quello con il corpo che invecchia.
Quando qualcuno muore non scompare semplicemente dal mondo fisico, ma continua a esistere in un altro modo: come ricordo, forma di memoria, racconto, dolore e nostalgia.
In questo senso, il rapporto con i morti è un apprendistato: ci insegna che l’esistenza personale non coincide completamente con la presenza biologica. Da soggetti che agiscono, i defunti possono divenire parte di noi stessi.
Ricordarli, parlarne, portarli con sé non è solamente un gesto affettivo, ma un esercizio concettuale che ci abitua all’idea del domani, quando noi stessi lasciamo una traccia negli altri.
I morti ci mostrano che non tutto ciò che conta deve essere attivo, visibile o funzionante. E così rendono pensabile il fatto che, un giorno, noi stessi potremo “esistere” senza esserci.
Se i morti ci preparano su quello del significato, il corpo che invecchia ci prepara su quello della necessità.
Finché il corpo è forte, rapido, efficiente, la morte appare come una violenza: un’interruzione insensata, una sottrazione arbitraria. Ma con il tempo il corpo introduce una logica diversa, perdendo forza, velocità, memoria e resistenza. Il corpo funziona, desidera, compete e ha bisogno di meno.
Non è soltanto decadimento; è trasformazione del ruolo. Progressivamente smettiamo di essere fatti per iniziare e diventiamo più adatti a concludere, divenendo portatori di esperienze. Il nostro posto nel mondo si sposta: dalla produzione alla trasmissione, dall’espansione alla conservazione, dall’apertura alla chiusura.
A un certo punto non è più il mondo che ci espelle, ma siamo noi che non siamo più fatti per il mondo così com’è: troppo veloce, troppo denso, troppo orientato alla prestazione. “Lasciare il posto” smette allora di sembrare una punizione e comincia ad apparire come una coerenza: il sistema biologico e quello sociale richiedono energie che non abbiamo più, e noi non desideriamo più ciò che essi richiedono.
La morte diventa così non solo una fine, ma una ritirata strutturale: cedere spazio, non solo perderlo.
Queste due linee lavorano insieme. I morti ci mostrano che si può continuare a esistere in un altro modo; il corpo ci ricorda che la nostra esistenza così com’è non può durare per sempre. Una prepara l’immaginazione, l’altra prepara la necessità.
Da questo incrocio la morte assume una differente prospettiva. Da soggetti a oggetti di memoria, da presenze a conseguenze, da voci a echi.
Questo non rende la morte buona, né giusta, né desiderabile. La morte resta spesso tragica, prematura, violenta. Ma smette di essere completamente assurda. Diventa una conclusione che la vita stessa prepara, lentamente, in modo imperfetto e doloroso, ma strutturale.
Imparare a morire non significa rassegnarsi. Significa comprendere che la vita contiene già in sé la forma della sua fine — non come negazione, ma come trasformazione del nostro modo di esserci.
Forse è questo il massimo che possiamo ottenere: non una consolazione, ma una intelligibilità. Una ragione per cui la morte non è soltanto un buco nero nel senso, ma un punto in cui il senso cambia forma.
Conclusione
A giorni, in occasione dell’anniversario della morte di mia madre, farò un viaggio per portare un fiore sulla tomba di sua madre — mia nonna — che non ho mai visitato prima. Non è un gesto rituale nel senso forte, né un atto di fede. È un modo per riconoscere una continuità: un passaggio di esistenze che non sono più presenti, ma che continuano a orientare la mia. Un modo per collocarmi, anche fisicamente, dentro una catena di vite che finiscono, ma non si annullano.
In questo gesto semplice — andare, fermarsi, lasciare un fiore, tornare — c’è forse l’intera forma di ciò che ho chiamato “imparare a morire”: non smettere di vivere, ma imparare a vivere sapendo che il nostro posto, un giorno, sarà quello che oggi hanno i nostri morti.
P.S.
Non sono mai stato prima sulla tomba di mia nonna a causa della distanza — geografica, pratica, organizzativa… ma non era tutto.
I luoghi non sono solo lontani nello spazio: lo sono anche nel senso. Finché un luogo non diventa necessario dentro, resta opzionale fuori. Non era ancora entrato nella mia geografia interiore. Non era ancora un punto della mappa che chiedesse di essere raggiunto.
C’è voluto tempo per poter andarci senza che fosse un gesto vuoto, accettando di essere colui che viene dopo, che raccoglie e si colloca in una catena. Visitare una tomba non è visitare un posto: è assumere una posizione.
Ora non ci vado per riparare qualcosa che ho mancato prima. Non ci vado per dovere. Ci vado perché questo gesto è diventato una conseguenza. È diventato semplice. È diventato giusto.
Non è rimandare, è lasciar maturare.


.png)
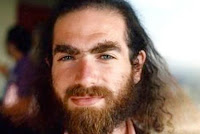





Commenti
Posta un commento